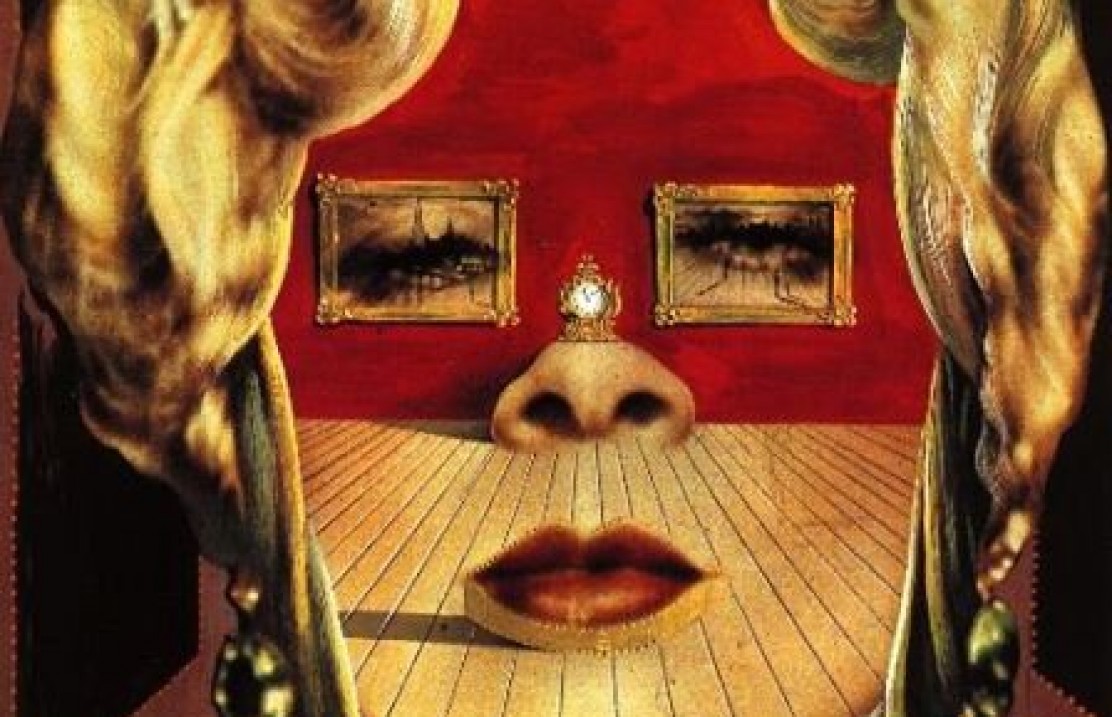Quando Paul Thomas Anderson è al cinema il weekend dura fino a giovedì. Premesso questo, insieme alla verità inconfutabile che i suoi film vanno visti almeno due volte, fossi in voi ne approfitterei di questo weekend lungo per vedere Il filo nascosto (Phantom Thread).

Bisogna dire fin da subito che il film è destinato ad entrare in una storia triste solo perché è probabilmente l’ultimo dell’attore britannico Daniel Day-Lewis ovvero, come disse qualcuno, “Il Federer della recitazione”, ma non è questo il punto. Se è vero che io sono un grande ammiratore di Anderson è altrettanto vero che si fa fatica a non ammettere che il regista americano non abbia ancora sbagliato un film (e forse nemmeno un’inquadratura) in tutta la sua carriera, ed è un peso che si porta dietro ma che in un certo modo non condivide con noi spettatori: ciò che voglio dire è che ogni qual volta vedo un film di Anderson mi viene da pensare “questo è il suo capolavoro”, come se azzerasse la filmografia, alleggerendo l’imponenza dei film precedenti. Questo non significa però che un po’ di The Master o di Il Petroliere non ci sia ne Il Filo nascosto, o che non ci sia un po’ di Hitchcock. Anzi, lo stile di Anderson (che qui cura anche la fotografia) è riconoscibile in tanti momenti, dalla pulizia, la cura delle immagini, al rimando finale della soluzione degli eventi narrati.
Ma di cosa parla questo film?
 Il filo nascosto è ambientato nella Londra degli anni ’50, (Anderson in un’intervista disse che gli anni ’50 sono i suoi anni preferiti), più in particolare nel mondo della moda artigianale: Reynolds Woodcock è uno stilista, maniaco del suo lavoro, ossessionato da questo e dalla sua quotidianità. Irrompe (sei qui per rovinare la mia vita?) nel suo mondo una meravigliosa ragazza che si presta come modella per le sue creazioni e con cui si instaura un rapporto molto strano sin dall’inizio del film, una relazione che metterà sottosopra la “casa” di Reynolds. È un film sulla moda? È un film sull’amore, sulle relazioni, sulle ripetizioni? È una specie di biopic, un film sulla figura dell’artista? Difficilmente ad un film di Anderson si può attribuire una direzione univoca. Le sensazioni provate durante e dopo la visione mi portano a parlare di un film sulla perversione, sull’ossessione.
Il filo nascosto è ambientato nella Londra degli anni ’50, (Anderson in un’intervista disse che gli anni ’50 sono i suoi anni preferiti), più in particolare nel mondo della moda artigianale: Reynolds Woodcock è uno stilista, maniaco del suo lavoro, ossessionato da questo e dalla sua quotidianità. Irrompe (sei qui per rovinare la mia vita?) nel suo mondo una meravigliosa ragazza che si presta come modella per le sue creazioni e con cui si instaura un rapporto molto strano sin dall’inizio del film, una relazione che metterà sottosopra la “casa” di Reynolds. È un film sulla moda? È un film sull’amore, sulle relazioni, sulle ripetizioni? È una specie di biopic, un film sulla figura dell’artista? Difficilmente ad un film di Anderson si può attribuire una direzione univoca. Le sensazioni provate durante e dopo la visione mi portano a parlare di un film sulla perversione, sull’ossessione.
Per la prima ora assistiamo ad una trama piuttosto lineare, inebriata da un’eleganza estrema, in cui la scrittura dei dialoghi e delle scene ci porta molto bene dentro la routine dell’artista, le sue ossessioni appunto, montature, la conoscenza con Alma (Vicky Krieps in una sontuosa prova). Tutto in scena è perfettamente funzionale a questa “presentazione”, il sonoro è impressionante, il suono assordante del coltello di Alma mentre imburra i toast distraendo Reynolds dal suo lavoro, il rumore del tavolino del ristorante dove per la seconda volta la sorella di Reynolds, in modo volontariamente fastidioso, entra a far parte della scena, rompendo uno dei primi e brevi momenti di intimità tra i protagonisti. Le colazioni, le abitudini alimentari, le visioni della madre di Reynolds che rafforzano l’attaccamento dell’artista al suo lavoro, intorno al quale per tutto il film Alma cerca di muoversi, inserirsi, sperimentare, rendendosi la vera protagonista del film (in effetti il regista, durante le riprese, ha detto alla Krieps che è il suo primo film con protagonista femminile). Il rapporto tra i due, che lasciava intravedere le sue particolarità fin dall’inizio, nella seconda ora di film diventa un rapporto davvero perverso, masochista, la malattia e la cura, l’avvelenamento incosciente e poi cosciente (baciami prima che cominci a sentirmi male) da funghi, progettato da Alma per ritagliarsi uno spazio più grande nella vita di Reynolds, per poi curarlo e ricreare ogni volta questa intimità che gli permette di ricominciare la routine professionale e di coppia. La perversione come il desiderio di reinventare la coppia ogni volta, di cadere e ricominciare.

C’è una delicatezza, un’estrema eleganza che copre tutte le azioni, la casa di Reynolds, il suo studio, le conversazioni dei personaggi, attributi che contribuiscono non solo all’identità del film (dopo la cui visione ti sembra volgare anche la tua faccia) ma che rendono precisa anche la claustrofobia (“c’è un’aria di morte in questa casa”, dice Reynolds) e l’erotismo della relazione. Non ci sono scene di sesso, appena due scene di bacio, eppure avvertiamo tutti gli aspetti estremi ed esasperanti di una storia d’amore, senza però vederli davvero rappresentati.
Anche la colonna sonora, qui del tutto originale (contrariamente al precedente (Inherent Vice) contribuisce in modo magistrale a tutto questo: Johnny Greenwood, genio musicale, (riduttivo è dire chitarrista dei Radiohead), alla sua ennesima collaborazione con Paul Thomas Anderson, realizza delle tracce classiche, per lo più composte da pianoforte e archi, che accompagnano e anticipano piuttosto fedelmente le sensazioni e i luoghi della narrazione. Una struttura scenica fatta per lo più da interni (vedi la claustrofobia di cui sopra), e anche quando si è in esterno, come durante il viaggio alpino si tende a stringere sull’oggetto primario statico o dinamico che sia, come nel caso delle meravigliose scene in automobile.

Insomma, un paio di visioni non credo che bastino per questo film e a me già manca, e sarò costretto a farmi fare un vestito su misura da un sarto, come 3 anni fa fui costretto a farmi crescere le basette alla Doc Sportello, come 6 anni fa volevo correre lungo un campo come Freddie Sutton, e così via. E poi, per quell’altra storia non so proprio che dire, Daniel Day- Lewis, fa’ presto ritorno, che ci sia ancora sangue.