Antefatto
Nel 2014, lo psicologo Aleksandr Kogan realizza un’app che permette di conoscere la propria personalità in base all’utilizzo di Facebook. L’unica azione da compiere è iscriversi tramite “Facebook Login”, il sistema di Facebook che permette di creare un profilo tramite le credenziali del social (quello che c’è anche su Spotify, per intenderci). Il sistema è «gratuito», che in rete significa che il prodotto sei tu. Utilizzarono l’app appena 270 mila persone, ma, secondo le regole di Facebook di allora, Kogan ottenne anche i dati dei loro amici: fu così che si ritrovò fra le mani un database di 50 milioni di profili, che comprendevano foto, “mi piace”, condivisioni, post pubblici. Kogan, andando contro le condizioni d’uso di FB, li condivise con una società inglese, Cambridge Analytica.

Cambridge Analytica
Cambridge Analytica era stata fondata un anno prima. È una società di marketing online che si occupa di raccogliere dati sui social, elaborarli tramite modelli e algoritmi e trovare i profili più adatti per la pubblicità mirata. Cambridge Analytica «sostiene di riuscire a individuare soggetti sensibili a operazioni di marketing, combinando la scienza comportamentale con l’analisi dei dati dei consumatori. Conduce sondaggi e raccoglie dati da un’ampia varietà di fonti, tra cui social network come Facebook.»[3]
Il nome della società viene dall’algoritmo sviluppato da un suo ricercatore, Michal Kosinki, che ha studiato a Cambridge. Il suo algoritmo è talmente sofisticato da ricavare dati psicologici da relativamente pochi “mi piace”: secondo il suo ideatore, con 70 mi piace si conosce la personalità di un utente meglio di quella dei propri amici; con 300 se ne sa più di quanto ne sappia il partner.
Sono stati dati in pasto a questo algoritmo i dati dei 50 milioni di profili dell’applicazione di Kogan: i dati non sono stati rubati, Facebook non è stata “hackerata”, tutto è avvenuto in totale trasparenza. Kogan ha semplicemente infranto una regola di Facebook, quella di non condividere con parti terze dati che ha ottenuto con gli strumenti forniti da Facebook stessa. Cambridge Analytica – attraverso tecniche psicometriche – poteva creare pubblicità personalizzata per ogni singolo utente fra quei 50 milioni (si chiama micro-targeting comportamentale).
A questo punto, un dipendente della società, Christopher Wylie, fa uscire la storia [1] raccontando tutto ai quotidiani statunitensi Observer, The Guardian e New York Times, che accusano Facebook di non aver bloccato la società. Continua a leggere
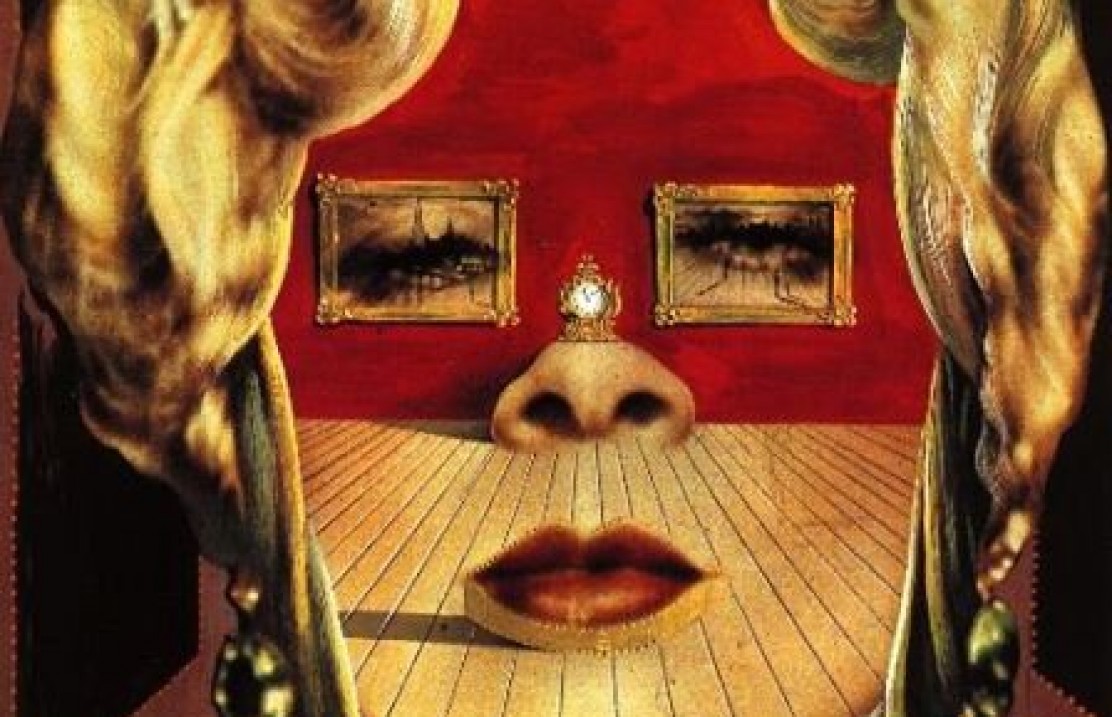
 statunitensi (fra cui Facebook, Microsoft, Google, Apple e Yahoo), aveva libero accesso a tutto quello che i cittadini degli Stati Uniti, e buona parte di quelli del mondo (fra cui almeno 10 milioni di italiani), facessero online [1]. Gleen Greenwald, il giornalista che intervistò Snowden sollevando il polverone, ritiene che la scusa adottata dall’NSA è tanto subdola quanto inutile: l’agenzia federale, infatti, basò la sua difesa su due punti: 1) il progetto serviva per la sicurezza nazionale e 2) se non si aveva nulla da nascondere, nulla c’era da temere. Greenwald, nel suo libro No place to hide, smonterà le argomentazioni dell’NSA in maniera molto efficace: per quanto riguarda il primo punto, la raccolta di dati non aveva portato a nessun arresto, mentre per il secondo scriverà che ci sono cose assolutamente legali che uno può fare, ma che fa solo finché sta da solo, senza nessuno lo stia osservando. Per il giornalista, infatti, tutto il progetto non serviva ad altro se non spiare la popolazione, che rappresenta la massima forma di controllo, istituendo diversi parallelismi con 1984 di Orwell. Ma il punto di questo articolo è un altro. All’epoca dei fatti, il 2013, i grandi colossi dell’Internet rilasciarono poche dichiarazioni rispetto alla gravità dell’accaduto, ma subirono il contraccolpo: nacquero e crebbero servizi che garantivano l’anonimato, come Telegram. Ed ecco che entra in scena il mercato.
statunitensi (fra cui Facebook, Microsoft, Google, Apple e Yahoo), aveva libero accesso a tutto quello che i cittadini degli Stati Uniti, e buona parte di quelli del mondo (fra cui almeno 10 milioni di italiani), facessero online [1]. Gleen Greenwald, il giornalista che intervistò Snowden sollevando il polverone, ritiene che la scusa adottata dall’NSA è tanto subdola quanto inutile: l’agenzia federale, infatti, basò la sua difesa su due punti: 1) il progetto serviva per la sicurezza nazionale e 2) se non si aveva nulla da nascondere, nulla c’era da temere. Greenwald, nel suo libro No place to hide, smonterà le argomentazioni dell’NSA in maniera molto efficace: per quanto riguarda il primo punto, la raccolta di dati non aveva portato a nessun arresto, mentre per il secondo scriverà che ci sono cose assolutamente legali che uno può fare, ma che fa solo finché sta da solo, senza nessuno lo stia osservando. Per il giornalista, infatti, tutto il progetto non serviva ad altro se non spiare la popolazione, che rappresenta la massima forma di controllo, istituendo diversi parallelismi con 1984 di Orwell. Ma il punto di questo articolo è un altro. All’epoca dei fatti, il 2013, i grandi colossi dell’Internet rilasciarono poche dichiarazioni rispetto alla gravità dell’accaduto, ma subirono il contraccolpo: nacquero e crebbero servizi che garantivano l’anonimato, come Telegram. Ed ecco che entra in scena il mercato. 


 Di conseguenza, più il fake – la “bufala” – è condiviso da persone che conosciamo e di cui ci fidiamo, più aumentano le possibilità di crederci a nostra volta. Nella seconda fase, l’équipe ha analizzato 4709 fake status pubblicati da pagine satiriche italiane considerate attendibili dagli internauti. Status condivisi (vedi il “Fai girare” tipico di molti di questi post) da utenti molto polarizzati, ovvero seguaci di numerose pagine di “controinformazione”.
Di conseguenza, più il fake – la “bufala” – è condiviso da persone che conosciamo e di cui ci fidiamo, più aumentano le possibilità di crederci a nostra volta. Nella seconda fase, l’équipe ha analizzato 4709 fake status pubblicati da pagine satiriche italiane considerate attendibili dagli internauti. Status condivisi (vedi il “Fai girare” tipico di molti di questi post) da utenti molto polarizzati, ovvero seguaci di numerose pagine di “controinformazione”.